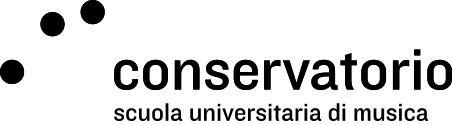Abstract: Il presente lavoro analizza l’importanza della componente emotiva nel processo di apprendimento musicale ed evidenzia come le emozioni, siano esse positive o negative, che intervengono nell’interazione tra allievo e insegnante influenzino significativamente il livello di motivazione, di prestazione e di soddisfazione dell’allievo durante e dopo la lezione. L’ipotesi di partenza è che l’adozione di strategie comunicative e relazionali mirate possa migliorare l’esperienza di apprendimento, facilitando l’acquisizione di competenze specifiche, sviluppando la motivazione e favorendo un clima di lavoro sereno. La sperimentazione, che ha coinvolto tre allieve di età compresa tra i dieci e i tredici anni, si è basata su un protocollo che prevedeva l’applicazione di specifiche strategie comunicative e relazionali nel corso di sei lezioni. I risultati confermano l’impatto che le emozioni esercitano sull’apprendimento e sulla performance a lezione. Un allievo sereno comunica meglio con l’insegnante, consolida e accresce il proprio interesse e sviluppa più facilmente le competenze necessarie per autoregolarsi. Nonostante non sia sempre facile per un insegnante adottare un approccio positivo ed accogliente, egli può mettere in atto strategie mirate, in grado di migliorare il benessere emotivo degli studenti, il loro livello di coinvolgimento e la loro motivazione.